Potenza e Resistenza. Attivo e Passivo. Dietro gli assedi, si celano Verità profonde che il Mito lascia filtrare a chi sa leggerle
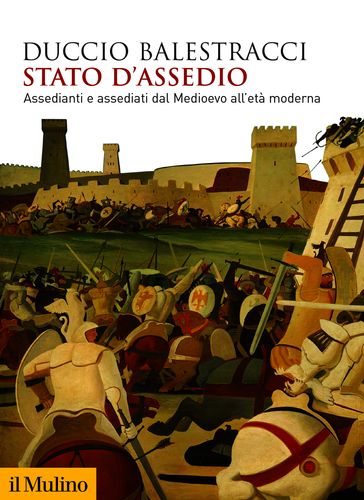
Fin dai poemi omerici non esiste una versione realmente affidabile di ciò che precedette e quel che seguì agli attacchi a fortezze o città. I racconti — spiega Duccio Balestracci in Stato d’assedio. Assedianti e assediati dal Medioevo all’età moderna, pubblicato dal Mulino — sono discontinui, caratterizzati da punti lasciati in ombra a favore di altri aspetti considerati salienti. E soprattutto «non sono quasi mai frutto di una lettura “terza”, ma, inevitabilmente, dell’appartenenza dello scrittore a uno dei due campi». In più sono sempre elaborati quando «tutto è finito (spesso, da tempo)», e così risentono «di una selezione e gerarchizzazione della memoria». Tra l’altro, fino a epoche molto vicine, «la storia è stata una branca della letteratura» sicché la storia degli eventi bellici ha attinto a piene mani dai «topoi letterari» che il canone, volta per volta, offriva.
Le vicende relative agli assedi sono, dunque, «romanzo» e del romanzo rispettano «la struttura e la forma». In che senso? La narrazione mostra «in filigrana l’interpretazione morale degli episodi». È sempre «sequenziale», ricca di aneddoti e di colpi di scena «alcuni dei quali talmente iperbolici da risultare, alla fine, perfino grotteschi». Racconta Flavio Giuseppe che nell’assedio di Iotapata (soldati di Vespasiano contro i Giudei, 67 d.C.) un proiettile romano avrebbe staccato la testa ad un assediato «facendola rotolare a quasi un chilometro di distanza» e una donna incinta avrebbe ricevuto un colpo al ventre di tale veemenza che il feto «sarebbe schizzato via a duecento metri dal cadavere».
Jean de Léry ebbe la «fortuna» di assistere dall’interno all’assedio dell’ugonotta Sancerre da parte delle truppe cattoliche del re di Francia Carlo IX. L’agonia (successiva al massacro della notte di San Bartolomeo) durò otto mesi a cavallo di due anni: il 1572 e il 1573. De Léry provò a catalogare i diversi personaggi incontrati durante la sua esperienza (il traditore, il rinnegato, il negligente, l’eroe, il virtuoso, l’esaltato), in quella che secondo Balestracci costituisce «una galleria di “tipi” che accede al mondo della rappresentazione teatrale, frequentemente evocata in questo genere di scrittura». E qui si può notare come il libro di Balestracci sia estremamente istruttivo per chi voglia trarre una lezione politica dalla lunga storia degli assedi.
In ogni guerra «l’importante è spaventare, demotivare, scoraggiare il nemico». Il sistema di infiltrarsi, «seminare dubbi e indurre a tradire» si è rivelato sempre assai efficace. Nel 1702 nel forte spagnolo di St. Augustine, in Florida, assediato dagli inglesi, arriva un indiano che dice di chiamarsi Juan Lorenzo: si presenta agli assediati come un disertore del contingente di indigeni arruolato dai britannici. Verrà poi scoperto mentre contatta gli indiani catturati per sobillarli e guidarne la ribellione. Mai fidarsi dei transfughi, è la lezione che si trae dal «caso di Juan Lorenzo».
L’assedio è «indubbiamente traumatico prima di tutto per chi sta dentro, asserragliato in perenne stato di incertezza e di timore». Ma questo non significa che la vita nel campo di chi assedia sia «priva di disagi, di problemi e di pericoli, non di rado esiziali». Anche se un accampamento, in realtà, quando è bene organizzato, «assomiglia a una piccola città». Poi, quando la partita è persa, «chi sta dentro» è costretto ad affrontare imprevedibili divisioni. Una «spaccatura radicale», ad esempio, dilania Costantinopoli allorché gli ottomani del sultano Maometto II si presentano in armi sotto le sue mura (1453). Si contrappongono «due gruppi entrambi rassegnati a dover scegliere il male minore in un esito ormai chiaramente nefasto». Quelli che preferirebbero finire in mano ai cattolici e gli altri che, a sorpresa, sostengono che è «meglio vedere imperare in mezzo alla città il vessillo dei turchi che quello dei latini».
L’essenza psicologica dell’assedio — oltre alla paura — è l’incertezza: «il continuo dubbio sulle scelte da fare, sugli errori da non compiere, sulle speranze che è logico coltivare e, al contrario, sui castelli in aria da evitare». A sua volta l’incertezza produce spesso divisioni che indeboliscono gli assediati. A Trieste nell’assedio del 1368-1369 la cittadinanza si divide tra chi vuole ad ogni costo la fine del conflitto e chi non è disposto alla resa. Sono a favore della pace gli esponenti di «quella che potremmo definire la borghesia cittadina, mercantile e artigianale», mentre vogliono resistere a oltranza i più poveri, quelli che «non hanno nulla da perdere».
Capita spesso che gli assediati abbiano delle idee che finiranno per danneggiarli. A Gerusalemme per esempio, quando arrivano i crociati (1099), «i turchi rendono inservibili le strutture di approvvigionamento idrico per un raggio di molti chilometri: guastano pozzi e cisterne e quei pozzi che non possono distruggere, li inquinano». Questo comportamento «costringe i contadini a rifugiarsi dentro le mura, oltre che per scampare alla furia dei cavalieri, anche per assicurarsi cibo e acqua». Si può pensare, scrive Balestracci, che in tal modo «gli assediati abbiano fatto altrettanto danno a sé stessi quanto agli assedianti». Forse addirittura di più.
Ogni volta, nel momento in cui inizia l’assedio, la campagna è la prima a farne le spese: «le devastazioni vengono da entrambe le parti, dai nemici e dagli “amici”». I contadini si trovano «a pagare il prezzo di una storia che, di fatto, li coinvolgerebbe solo di sponda, ma che, al contrario, li investe talvolta altrettanto duramente quanto gli abitanti della città». Le popolazioni delle campagne, alle prime avvisaglie di incursioni, si rifugiano spesso dentro le mura urbane cinte d’assedio, perché considerano preferibile non essere «preda e vittima designata delle razzie e delle violenze degli eserciti di entrambe le parti». In questo modo trasformano la città in un «rifugio dei disperati» difficile da governare quando giunge l’ora della verità. Oltretutto tra contadini e abitanti della città non si stabilisce un buon clima.
Su quel che accadde a Pisa, assediata più volte dai fiorentini (1494-1509), gli storici hanno raccontato spesso del «malanimo contadino verso la popolazione urbana» — o forse sarebbe meglio dire», specifica Balestracci, «dei dirigenti e dei ceti eminenti pisani» — al punto che «i villani sono stati considerati la punta più critica di destabilizzazione della situazione interna». Come se i contadini non fossero animati da «spirito patriottico» e fossero interessati esclusivamente a mettersi in salvo, lasciando l’onere della difesa agli abitanti della città. Una «sorta di spina nel fianco delle istituzioni che ha contribuito, alla fine, a far collassare la difesa antifiorentina». In realtà le cose non stanno affatto così. I contadini si dimostrano «altrettanto intransigenti difensori della libertà pisana quanto i cittadini». Quando i fiorentini assaltano il forte di Stampace (1499), sono loro che trascinano gli altri difensori su posizioni più intransigenti, rifiutano ogni accordo con il nemico e danno prova di una determinazione che va di là di quel che ci si sarebbe potuto aspettare. Cosa che — cinque anni dopo, alla fine del conflitto — verrà riconosciuta dagli stessi assalitori.
Paradossalmente la disperazione in qualche caso può provocare un effetto propizio. Secondo Flavio Giuseppe, «quando non c’è speranza di salvezza, è il momento giusto per attaccare battaglia». Una convinzione che si ritrova anche in Vegezio (vissuto tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C.) secondo il quale «la disperazione può essere generatrice di gesti virtuosi ed eroici». Fuggire poi non è sempre facile, anzi, in qualche caso può essere «più pericoloso che restare».
Chi prova ad andarsene da Vienna assediata dai turchi nel 1683, corre il rischio di incappare nei reparti tartari, ma anche — ed è quasi peggio — nei «contadini inferociti per lo stato di guerra». I quali, scrive Balestracci, «si trasformano di fatto in altrettanti predoni di strada, pronti a saltare addosso a chiunque gli capiti tra le mani».
Gli uomini di cultura, anche i più importanti, non sempre si mostrano all’altezza degli standard etici ai quali dovrebbero attenersi. Michelangelo Buonarroti prova a scappare (con dodicimila fiorini d’oro nascosti in tre giacconi) dalla Firenze assediata da Carlo V (1529). La signoria minaccia di confiscare le sue proprietà, a quel punto, e l’artista intavola una trattativa perché gli sia garantito il perdono e gli sia assicurata la conservazione dell’intero patrimonio. Dopodiché, quando cadrà la Repubblica, si nasconderà in casa di un amico e lì «aspetterà che, ancora una volta, la sua fama di artista gli salvi la vita». Un comportamento, scrive Balestracci, non proprio «specchiato» sotto il profilo civico. Non c’è quasi assedio finito male in cui l’esito infausto non sia stato attribuito ad un «più o meno plausibile tradimento».
C’è poi il problema vitale del cibo. De Léry sostiene che a Sancerre gli abitanti affamati si sarebbero nutriti di sterco di cavallo e d’uomo (asserendo che ha lo stesso sapore del pane di crusca). Ancora. De Léry riferisce alcuni episodi di cannibalismo: una famiglia avrebbe ucciso un bambino per potersi cibare delle sue carni e mettere poi sotto sale le rimanenze in modo da poterle mangiare nei giorni successivi; per un tal crimine il padre sarebbe stato processato, condannato e bruciato vivo, mentre la moglie sarebbe stata impiccata. Secoli prima, Rodolfo di Caen riferì essergli stato raccontato da persone degne di fede che, dopo aver espugnato Marra (1098), i crociati, in preda alla fame, si sarebbero cibati dei cadaveri dei musulmani e di quelli dei cani. Flavio Giuseppe riferisce che, mille anni prima ancora, durante la guerra giudaica (70 d.C.), Maria di Eleazar del villaggio di Bethezuba avrebbe cucinato un figlioletto per offrirlo a banditi affamati. Nel corso dell’assedio ugonotto a Parigi (1590) soldati avrebbero dato la caccia ai bambini per cibarsene: anche qui le madri avrebbero ucciso i figli e ancora una volta avrebbero messo «le parti avanzate in salamoia così da farle durare più a lungo». Ma, precisa Balestracci, si tratta di un racconto «liquidato come leggenda dagli stessi testimoni cattolici presenti nella città».
In conclusione? La Bibbia parla chiaro: quando avrai conquistato una città nemica, nel caso in cui essa non pratichi la «vera» religione (quella ebraica), «la metterai al sacco e i maschi li ucciderai tutti, dal momento che il divieto di uccidere vale solo per il popolo di Dio». Il bestiame, le donne, i bambini faranno parte, invece, del bottino. Cioè saranno «carne da stupro» per il fatto che su di loro si accumula «un mix di sfogo sessuale fine a sé stesso e di vendetta».
Allorché l’esercito crociato conquista Lisbona (1147), Arnulfo di Aershot riserva un trattamento di favore al capo della comunità musulmana, ma gli strappa una giumenta gravida. E lo fa con tale violenza da far abortire il povero animale. I musulmani per vendetta mettono in giro la voce che Arnulfo abbia avuto rapporti sessuali con il quadrupede. Quando gli àvari conquistano Cividale del Friuli (610 circa) il figlio più piccolo del duca Gisulfo afferra una spada e riesce a uccidere il predone che lo ha catturato. Le sue sorelle, per non essere violentate si mettono tra i seni fasciati carne di pollo putrefatta; gli assalitori ne traggono la convinzione che le donne longobarde hanno un odore ripugnante e quindi rinunciano a toccarle. Nel 1537 Sofì Pascià si accorda con gli abitanti di Castro (Corfù) promettendo loro la vita in cambio della resa. Poi però non mantiene l’impegno. Il sultano Solimano appena viene a conoscenza dell’accaduto, fa catturare Sofì Pascià, lo mette a morte e libera gli abitanti di Castro ridotti a schiavi.
Talvolta la foga distruttiva di una conquista fa sì che tutto sia ridotto in cenere e i conquistatori restino a bocca asciutta. È quel che accade a Béziers nel 1209 e ad Arlon nel 1558. La resa non è considerata necessariamente un’ignominia; però deve essere «senza infamia» cioè senza alternative. La presa di una città che non si arrende sfocia regolarmente in un esito sanguinoso. Ma la famosa frase dell’abate Arnaldo Amalrico davanti a Béziers (1209), riportata da Cesario di Heisterbach («Uccideteli tutti: Dio riconoscerà i suoi»), non fu mai pronunciata. Va considerata falsa. «Come la quasi totalità delle frasi famose», scrive Balestracci.











